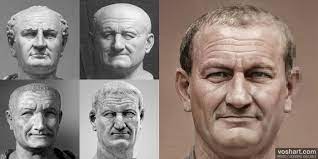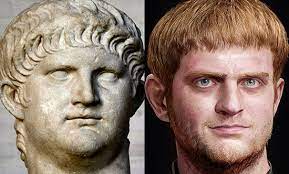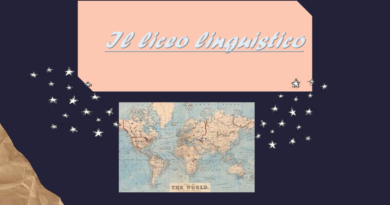Carta identità ( Vespasiano)
Quintus Romanorum imperator…
Nome originale: Titus Flavius Vespasianus
Nascita: Vicus Phalacrinae, 17 novembre 9
Morte: Roma, 23 giugno 79
Nazionalità: latino
Dinastia: Flavia
Coniuge: Flavia Domitilla maggiore, Caenis
Figli: Tito, Domiziano, Flavia Domitilla
Padre: Tito Flavio Sabino
Madre: Vespasia Polla
Regno: 69-79 d.C.
Descrizione fisica:
“Fu di statura massiccia, di membra saldamente compatte, di volto quasi contratto dallo sforzo: a
proposito di questo un cittadino molto spiritoso, al quale aveva chiesto di dire una battuta su di lui,
rispose: «Lo farò, quando avrai smesso di alleggerire il tuo ventre.» Godette di ottima salute,
sebbene per conservarla si limitasse a frizionarsi ritmicamente la gola e le altre parti del corpo in
una palestra destinata al gioco della palla e a digiunare un giorno al mese. “
(Svetonio, VIII,20)
Cursus honorum: 30 d.C. venne mandato come laticlavio in Tracia per circa 3 o 4 anni
34 d.C. divenne questore nella provincia di Creta e Cirene
38 d.C. ricoprì la carica di edile dopo essere stato respinto la prima volta
Svetonio racconta un curioso episodio di questo periodo:
“In séguito, quando Vespasiano rivestiva la carica di edile e C. Cesare, adiratosi perché non aveva
provveduto a far spazzare le strade, ordinò ai soldati di farlo imbrattare stipando fango nelle
pieghe della sua pretesta, non mancarono quelli che interpretarono il fatto come se un giorno lo
Stato, calpestato e derelitto per qualche sconvolgimento politico, dovesse rifugiarsi sotto la sua
tutela e quasi nel suo grembo.”
(Svetonio, VII, 5)
Nel 40 d.C. divenne pretore, come ci racconta Svetonio:
“Da pretore, per non trascurare alcun mezzo di ingraziarsi Gaio, che era ostile al Senato, in onore
della sua vittoria sui Germani sollecitò giochi straordinari e, come aggravante alla pena dei
congiurati, stabilì che fossero lasciati senza sepoltura. Lo ringraziò anche davanti al Senato di
avergli fatto l’onore di un invito a cena.”
Dal 43 al 50 d.C. Vespasiano partecipò come legatus legionis della legio II Augusta alla conquista
della Britannia
Di questo periodo militare Svetonio ricorda:
“[…] ebbe trenta scontri con il nemico. Costrinse alla resa due popolazioni, più di venti città
fortificate e l’isola di Vette, che è molto vicina alla Britannia, agli ordini sia del legato consolare
Aulo Plauzio sia dello stesso Claudio. Per questo ricevette le insegne del trionfo e, in breve tempo,
due sacerdozi, e inoltre un consolato che esercitò negli ultimi due mesi dell’anno.”
(Svetonio, VII, 4)
Cassio Dione Cocceiano aggiunge un episodio curioso ed eroico in Britannia:
“Sempre in questo periodo in Britannia, Vespasiano venne colto di sorpresa dai barbari,
rischiando di essere ucciso, ma suo figlio Tito, preoccupato per il padre, con una grande audacia
spezzò l’accerchiamento, e dopo aver iniziato a respingere i nemici in fuga, ne fece una strage.”
(Cassio Dione, LX, 30.1)
Nel 51 d.C. fu console per gli ultimi due mesi dell’anno, fino a quando non ottenne il proconsolato,
Svetonio di lui disse che:
“Il periodo di tempo fino al consolato, lo passò in appartato riposo, temendo Agrippina, che aveva
ancora molto potere presso il figlio e odiava l’amico del pur defunto Narciso.”
(Svetonio, VII, 4)
Nel 63 d.C. andò come governatore in Africa proconsolare dove, secondo Svetonio, il suo governo
fu condotto con assoluta integrità e onore. Certo è che la sua fama e visibilità a Roma, crebbe.
Svetonio aggiunge:
“Non ritornò di certo più ricco, giacché, compromesso ormai il suo credito, ipotecò tutte le
proprietà al fratello e, di necessità, per sostenere le spese del suo rango, dovette abbassarsi a
traffici da mercante di bestiame; perciò era comunemente soprannominato «il mulattiere.”
Fu infatti in Grecia al seguito di Nerone. Svetonio ne racconta un episodio curioso:
“Durante il viaggio in Acaia, al seguito di Nerone, poiché, mentre l’imperatore cantava, o si
allontanava troppo spesso o sonnecchiava alla sua presenza, si tirò addosso un danno enorme e,
trovatosi escluso non solo dalla vita di corte ma anche dalle pubbliche udienze, si ritirò in una
cittadina fuori mano fino a quando, mentre se ne stava nascosto e temeva ormai il peggio, gli fu
offerto il governo di una provincia e il comando di un esercito.”
(Svetonio, VII, 4)
Dal 66 d.C. fino al 68 d.C. condusse la guerra giudaica
Secondo una profezia di Svetonio:
“In tutto l’Oriente si era diffusa un’antica e persistente credenza secondo cui era scritto nei fati che
quanti in quel tempo fossero venuti dalla Giudea si sarebbero impadroniti del sommo potere”
(Svetonio, VII, 4)
Svetonio aggiunge un episodio curioso di questi anni di guerra:
“In Giudea, quando consultò l’oracolo di Giove Carmelo, le sorti gli confermarono la promessa
che si sarebbe avverato tutto ciò che di più grandioso egli concepisse e desiderasse. E uno dei
notabili prigionieri, Giuseppe, mentre veniva costretto in catene, tenacemente assicurava che
presto sarebbe stato liberato dallo stesso Vespasiano, una volta divenuto imperatore.”
(Svetonio, VII, 5)
Nel 68 d.C. dopo la morte di Nerone vennero eletti 4 imperatori nel giro di pochi anni l’ultimo di
questi era proprio Vespasiano
Riforme
Riforme finanziarie
1) Chiese l’esazione delle imposte non pagate sotto Galba, introducendone poi di nuove e ancora più
gravose
2) Aumentò i tributi delle province, anche raddoppiandoli in alcuni casi
3) Ebbe nel complesso un occhio attento sulle finanze pubbliche. Sembra infatti che la sua sia stata
una illuminata economia, che, nello stato disordinato delle finanze di Roma, era una necessità
assoluta a causa dell’immensa povertà in cui versava sia il fiscus sia l’aerarium da come possiamo
vedere dalle parole di Svetonio:
“Vi sono invece altri che ritengono che egli sia stato spinto a saccheggi e rapine dalla necessità,
per l’estrema povertà dell’erario e del fisco, che aveva denunciato sùbito fin dall’inizio del suo
principato, dichiarando che «erano necessari quaranta miliardi di sesterzi perché lo Stato potesse
reggersi”
(Svetonio, VII, 16)
Riforme amministrative
1) Promulgò la lex de imperio Vespasiani, in seguito alla quale egli e gli imperatori successivi
governeranno in base alla legittimazione giuridica e non più in base a poteri divini come avevano
fatto i Giulio-Claudii. Questo provvedimento può essere riassunto in due formule: «il principe è
svincolato dalle leggi» (princeps a legibus solutus est); «quanto piace al principe ha vigore di
legge» (quod placuit principi legis habet vigorem).
2) Riformò il Senato e l’ordine equestre, rimuovendone i membri inadatti e indegni e promuovendo
uomini abili e onesti, sia tra gli Italici sia tra i provinciali, allo stesso tempo, rese questi organismi
più dipendenti dall’imperatore, esercitando la sua influenza sulla loro composizione.
3) Cambiò lo statuto della guardia pretoriana, formata da nove coorti in cui, per aumentarne la
fedeltà, furono arruolati solo italici.
4) Diede una pensione di cinquecentomila sesterzi all’anno ai consolari poveri. Svetonio aggiunge:
“E, affinché fosse ben chiaro che i due ordini differivano tra loro non tanto per i diritti quanto per
il rango, in una lite sorta tra un senatore e un cavaliere romano sentenziò che non si dovevano
ingiuriare i senatori, ma che, comunque, ricambiare gli insulti era un diritto civile e morale”
(Svetonio, VII, 9)
Riforme giudiziarie
Fece decretare dal Senato che ogni donna libera, che si fosse concessa a uno schiavo di altri, venisse
considerata anch’essa una schiava e che gli usurai, quando avessero concesso un prestito a un figlio
di famiglia, non potessero esigerne la restituzione neppure dopo la morte del padre.
Riforme sociali
1) Spesso offriva banchetti sontuosi per far guadagnare i macellai.
2) In occasione dei Saturnalia offriva doni agli uomini e alle calende di marzo alle donne
3) Nel 73 Vespasiano e Tito rivestirono una magistratura repubblicana ormai quasi dimenticata, la
censura, con l’obiettivo di ampliare il pomerium, ovvero il confine sacro della città, e iniziare una
generale ristrutturazione urbanistica. Ciò viene detto anche da Svetonio:
“Roma era deturpata dai segni di crolli e di passati incendi; e Vespasiano permise a chiunque di
occupare le aree vuote e di costruirvi sopra se i proprietari non prendevano iniziative.”
(Svetonio, VII, 8)
Riforme architettoniche
1) Ricostruì il Campidoglio, dando lui stesso una mano a rimuovere le macerie e trasportandole
personalmente in spalla; in questa circostanza fece rifare tremila tavole in bronzo, andate
completamente distrutte nel recente incendio, dove erano conservati i senatoconsulti fin quasi dalla
fondazione della città, i plebiscita, i trattati e le alleanze;
2) Iniziò la costruzione di un nuovo e funzionale foro con annesso un tempio dedicato alla Pace. Il
grandioso complesso fu decorato con le statue raccolte da Nerone in Grecia e in Asia Minore,
antichi capolavori di pittura e di scultura, oltre che con la suppellettile d’oro presa nel tempio dei
Giudei, di cui Vespasiano andava fiero.
3) Iniziò la costruzione del Foro Transitorio. Definito dai contemporanei come una delle meraviglie
del mondo
4) Portò a termine sul Celio il tempio del Divo Claudio, iniziato da Agrippina ma quasi interamente
demolito da Nerone fino alle fondamenta;
5) Dispose la costruzione nonché la tassazione di numerosi orinatoi, che presero il nome di
“vespasiani”;
6) Realizzò, infine, un grandioso anfiteatro, il Colosseo, simbolo ancora oggi dell’antica Roma,
nell’area che sapeva essere stata a ciò destinata da Augusto.
7) Fece inoltre ampliare un altro grande anfiteatro, l’arena di Pola, che fu costruita nella prima metà
del I. secolo d.C.
8) Fece potenziare e manutenere i più importanti tratti viari della penisola e in particolare le vie
Appia, Salaria e Flaminia.
9) Il successivo incendio della Domus Aurea danneggiò il colosso di Nerone che fu restaurato da
Vespasiano, il quale lo convertì in una rappresentazione del dio Sole.
Riforme culturali
Egli fu il primo imperatore a stanziare una somma di centomila sesterzi all’anno a favore di retori
greci e latini. Versò numerosi congiaria ai poeti più importanti, ai migliori artigiani. Altri
ricevettero un vitalizio di più di mille pezzi d’oro all’anno. Svetonio racconta che:
“Fu il primo ad assegnare, attingendo al fisco, una pensione annua di centomila sesterzi per
ciascuno ai retori latini e greci; i poeti più insigni, nonché gli artisti, come il restauratore della
Venere di Coo e così pure quello del Colosso, gratificò con ricchi donativi e lauti stipendi, e anche
a un ingegnere, che assicurava di poter trasportare sul Campidoglio con modica spesa alcune
enormi colonne, offrì un premio non indifferente per il progetto, ma poi rinunciò all’esecuzione
dell’opera dicendogli che gli lasciasse sfamare il popolino.”
(Svetonio, VII, 18)
“Per gli spettacoli con cui si inaugurava la scena restaurata del teatro di Marcello, aveva
richiamato anche vecchi artisti. All’attore tragico Apellaride donò quattrocentomila sesterzi, ai
citaredi Terpno e Diodoro duecentomila ciascuno, centomila ad alcuni altri e, come minimo,
quarantamila, oltre a moltissime corone d’oro.”
(Svetonio, VII, 19)
Si aggiunga che i maestri della filosofia stoica e scettica, attivi in Roma, erano stati perseguitati per
la loro opposizione al regime di Vespasiano. Ostilio e Demetrio erano stati mandati in esilio ed
Elvidio Prisco, che si era rifiutato di riconoscere Vespasiano quale imperatore, fu messo a morte. Il
potere imperiale considerava intollerabile la loro indipendenza di giudizio e se essi generalmente
non erano politicamente attivi, erano però moralmente autorevoli e le loro critiche erano tanto più
pericolose in quanto venivano diffuse pubblicamente tra i loro allievi.
La grande opera di Plinio il Vecchio, Naturalis historia, fu scritta durante il regno di Vespasiano e
dedicata a suo figlio Tito. Alcuni filosofi, avendo parlato con rimpianto dei tempi d’oro della
Repubblica, e quindi indirettamente incoraggiato cospirazioni, indussero Vespasiano a rimettere in
vigore le leggi penali contro questa professione ormai obsoleta; solo uno di essi, Elvidio Prisco, fu
messo a morte, perché aveva affrontato l’imperatore con insulti studiati. “Non ucciderò un cane che
mi abbaia contro”.
Riforme militari
Con Vespasiano, venne ripristinata l’antica disciplina militare, ma soprattutto si preoccupò di
evitare che l’eccessiva devozione delle legioni ai propri comandanti potesse generare una nuova
guerra civile. La caduta di Nerone era seguita da una lotta che aveva, non solo portato distruzione
nella penisola italica e dissanguato le casse dello stato, ma aveva coinvolto numerosi eserciti. Fu
necessario porre rimedio a ciò attraverso una nuova serie di riforme, che completasse quanto era già
stato fatto durante la dinastia giulio-claudia:
1) sciolse ben quattro legioni che avevano trascinato nel fango le proprie insegne macchiandosi di
disonore e ne riformò tre nuove dando la possibilità ad alcuni di fare pubblica ammenda;
2) avendo trovato le casse dell’aerarium militare pressoché vuote, mise in atto tutta una serie di
azioni per ripristinare la precedente situazione finanziaria alla guerra civile;
3) data inoltre la crescente scarsità di reclute decise di aumentare l’impiego di truppe ausiliarie
provinciali, facendo in modo che le generazioni future avessero un numero maggiore di potenziali
cittadini romani da arruolare nelle legioni. Di contro si andava a creare una vera e propria
rarefazione dell’elemento italico a vantaggio di quello provinciale, pur non producendo mutamenti
sostanziali nel valore militare complessivo;
4) al fine di aumentare la capacità difensiva dei confini imperiali per tutta la loro lunghezza, oltre
9.500 km terrestri, dispose di ricostruire numerose fortezze legionarie in pietra ed in posizioni
strategicamente migliori, in modo da non trascurare la sicurezza delle legioni dove erano
acquartierate;
5) non trascurò il fatto che le truppe di confine, quando rimanevano inattive per troppo tempo, in un
ambiente ospitale, perdevano la loro capacità di combattere. Queste truppe, non avendo infatti una
prospettiva immediata di guerra o di bottino, rischiavano di perdere la proverbiale disciplina e
deteriorarsi. Solo un allenamento costante poteva preservare le capacità di combattimento, anche in
tempo di pace, ben sapendo che dai primi accampamenti “rurali” si era ormai passati a fortezze che
andavano sempre più acquisendo una tipica atmosfera urbana;
6) tornò all’ordinamento augusteo, riducendo le coorti pretoriane a 9
7) La riforma della prima coorte potrebbe essere avvenuta all’epoca di Augusto o forse al tempo dei
Flavi. Si trattava di una coorte militare, vale a dire di dimensioni doppie rispetto alle altre nove
coorti, con 5 manipoli di 160 armati ciascuna, pari a 800 legionari, a cui era affidata l’aquila della
legione. Primo esempio di costruzioni che ne ospitassero una coorte di queste dimensioni la
troviamo nella fortezza legionaria di Inchtuthill in Scozia.
Politica estera
Ridusse a province l’Acaia, la Licia, Rodi, Bisanzio e Samo, togliendo loro la libertà, e fece lo
stesso con la Cilicia Trachea e la Commagene, che fino ad allora erano state governate da re